La Fotografia è utile in tempo di guerra?
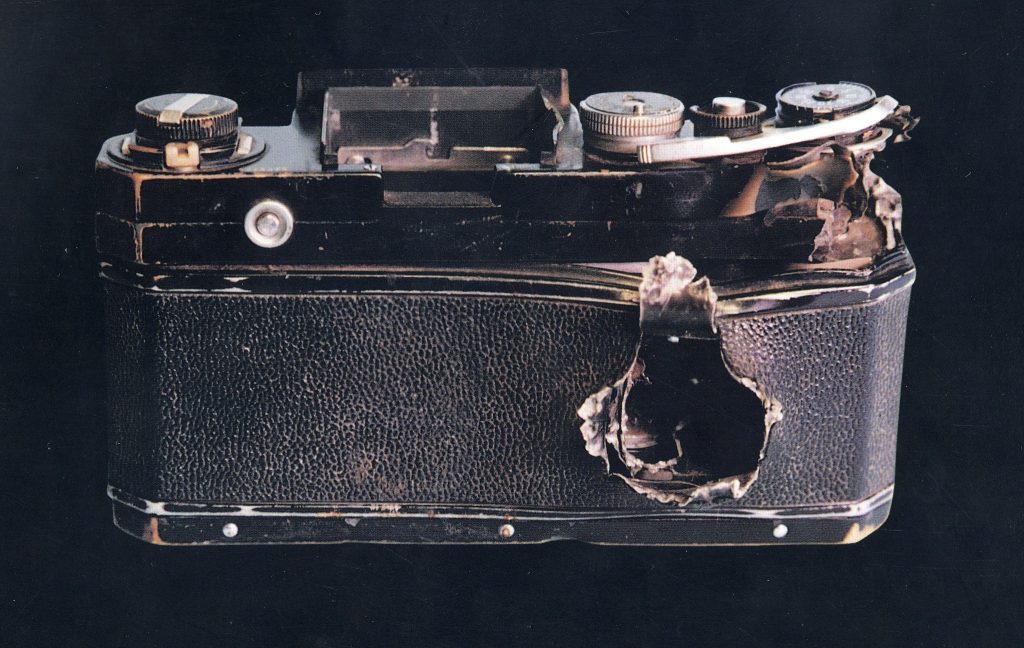
Non sono un fotografo di guerra e questa premessa è importante. Oltre a fotografare matrimoni faccio anche fotografia documentaria e sociale, ma niente guerra. Io sto scrivendo comodamente seduto sul mio divano di casa, con il camino acceso, ascoltando della buona musica. Per questo non entrerò nel merito e tantomeno commenterò ciò che sta accadendo in Ucraina e il lavoro di coloro che stanno ‘sul campo’ a rischio della vita. Non solo non ho le conoscenze e le competenze necessarie per farlo, ma qualsiasi mia analisi sarebbe condizionata dalla mia posizione di assoluta ‘tranquillità’ almeno nei limiti in cui riesco a vivere il quotidiano praticamente come un mese fa. Credo, però, che le considerazioni che seguono vadano aldilà della sfera professionale e tocchino, invece, argomenti sui quali ci si può fermare a riflettere.
La fotografia è utile in tempo di guerra? Mi sono posto tante volte questa domanda e in questi giorni è tornata prepotente a martellarmi la testa. Certamente non sono stato il solo a porsela. Don McCullin, uno tra i più importanti fotografi di guerra contemporanei, ha creduto per tanto tempo che fosse un suo dovere quello di documentare e che il suo lavoro potesse cambiare il corso degli eventi e rendere la guerra una sorta di tabù. Ma negli ultimi anni, probabilmente deluso dal mondo e dagli uomini, ha rinnegato questa sua visione nella consapevolezza che la fotografia, pur avendo un ruolo importante nel documentare, non è riuscita a far cessare le guerre. Ma allora qual è il compito della fotografia nelle zone di guerra?
James Nachtwey, un altro punto di riferimento del fotogiornalismo mondiale e tra i fotografi presenti adesso in Ucraina, sottolinea la necessità della fotografia come testimonianza. Nachtwey sente l’esigenza di scattare per non dimenticare e per far sì che certi drammi non si ripetano in futuro (compito, ahimè, smentito dall’attualità).
Ma cosa testimonia la fotografia di guerra? Cosa ci racconta l’immagine di un corpo coperto da un telo bianco? Ci mostra probabilmente un essere umano ucciso, ma qualora fosse così, chi è stato ad ammazzarlo, era un civile o un militare, a sparare è stato il nemico oppure quel corpo rientra in un eventuale ‘danno collaterale’ causato da fuoco amico? La fotografia purtroppo non dimostra niente, si limita a mostrare ciò che è davanti a chi scatta, ma non ci dà delle risposte.
Anzi, talvolta la fotografia è l’arma migliore della propaganda diventando uno strumento che mistifica e distorge la realtà. Fino alla metà del secolo scorso le fotografie di guerra dovevano essere autorizzate dalla censura militare prima di essere pubblicate su qualsiasi magazine o quotidiano. Il popolo americano si rese conto della drammaticità della guerra del Vietnam solo dopo che questa pratica si allentò e iniziarono a girare le immagini di Griffiths, di Ut, di McCullin, di Adams. Oggi la censura, almeno sulla carta, non esiste più, ma la mediazione giornalistica del direttore di un quotidiano può comunque condizionare l’opinione pubblica ponendo in prima pagina una specifica fotografia: un’immagine colpisce le coscienze più di qualsiasi testo scritto e un titolo può condizionare e amplificare la potenza visiva di quella stessa immagine trasformando il fatto in notizia.
E allora come fare a uscire fuori da questo cortocircuito? Come fare a formarsi un’opinione obiettiva? Come fare a districarsi in questo labirinto di immagini? Tra l’altro il corrispondente di guerra, il fotoreporter al fronte per documentare, è necessariamente embedded e quindi è quasi costretto a prendere una posizione se vuole lavorare. Adesso sul campo ucraino ci sono dei bravissimi e impavidi professionisti, fotografi che sanno fare magistralmente il loro lavoro. Vedo tantissime immagini sui social che ci raccontano storie di dolore e sofferenze, drammi familiari e sociali, distruzioni, atrocità, ma, per quanto appena detto, raccontano solo ciò che accade da una parte dei belligeranti. Per carità non voglio essere frainteso. E’ ben chiaro chi sia l’aggressore e chi sia l’aggredito. Chi con il maglione in cachemire e piumino Loro Piana incita, una folla ignara, alla ‘soluzione finale’ e chi, come un capitano che non abbandona la nave che sta affondando, infonde coraggio camminando tra la sua gente sotto i bombardamenti. Ed è altrettanto chiaro che non esiste una sola ragione – almeno a mio avviso – che giustifichi l’invasione di uno stato sovrano che sta comportando un folle numero di morti tra militari e civili, che sta creando orfani e profughi le cui tristi conseguenze non termineranno certo con la fine della guerra.
Credo, però, che le fotografie, in linea con il pensiero del fotoreporter Paolo Pellegrin, non siano in grado di dare delle risposte, non abbiano la capacità di fornire una visione oggettiva qualsiasi sia l’evento documentato. Inevitabilmente il fotografo è condizionato – volontariamente o meno – dall’ambiente, dalle sue capacità e dal suo essere interprete della realtà. Il fotografo non potrà mai essere un testimone neutrale, ma, a mio avviso, con le sue immagini, dovrebbe essere da stimolo alla riflessione, dovrebbe porre dei dubbi, dovrebbe sollecitare delle domande, dovrebbe mostrarci la crudeltà della guerra, dovrebbe essere un mezzo, ma non l’unico, per aiutarci a capire. I fotografi, adesso sul campo, fanno un lavoro mirabile e prezioso, ma non facciamo l’errore di credere che sia la fotografia a mostrarci tutta la verità. Non affidiamo alla fotografia un ruolo che non le appartiene. La fotografia mostra, non dimostra.



